Sole delle Alpi: altre interpretazioni
di Giuseppe Aloè
Tutto quanto segue, immagini comprese, è tratto dal n° 12 dei Quaderni Padani
editi d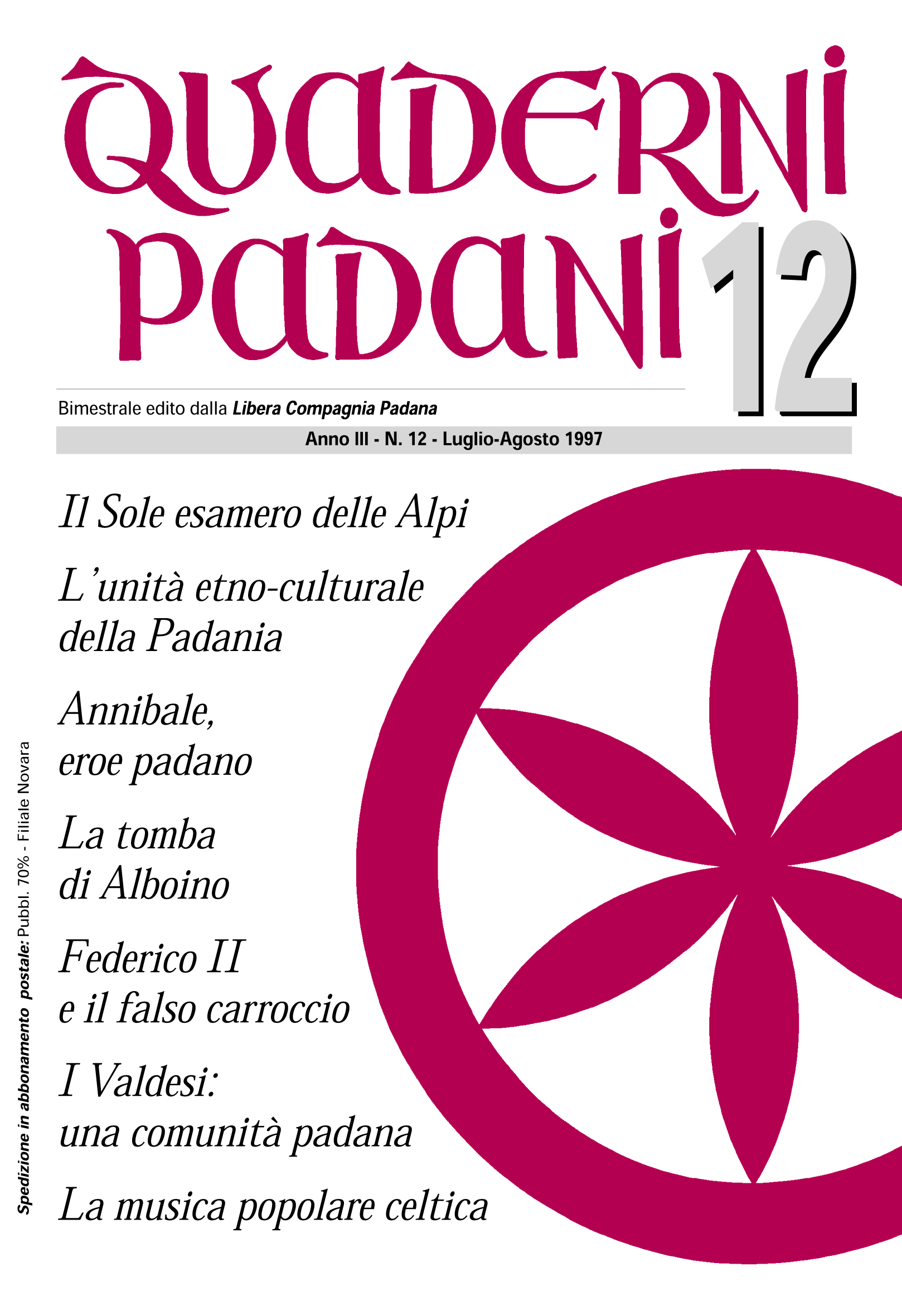 alla Libera Compagnia Padana a cui
consiglio di associarsi.
alla Libera Compagnia Padana a cui
consiglio di associarsi.
Il “Sole delle Alpi”, simbolo dell’identità Padana, ha una valenza di significati estremamente vasta e vorrei, con questo articolo, allargare un poco lo sguardo su ciò che sta dentro la sintetica, ma possente, forza suggestiva del linguaggio simbolico, avventurandomi nell’amplificazione dei significati nascosti e sovraconsci che un simbolo ci può rivelare. Naturalmente, il simbolo è sovraculturale, essendo l’archetipo gerarchicamente superiore al logos per cui un’amplificazione, sia pur ridotta, di un simbolo deve far riferimento anche a culture lontane per poterne cogliere tutta l’ampiezza. Tenterò, quindi, di dare una piccola immagine del “Sole delle Alpi” studiandolo simbolicamente da diversi punti di vista, e valutandolo rispetto alle singole caratteristiche: numero, forma, colore, eccetera.
Interpretazione riguardo al numero. Le sei
foglie del simbolo richiamano chiaramente il numero sei ed il numero sette
(sei foglie più il centro). Il numero sei è il numero sacro dello
Shaktismo e del Tantra essendo il numero delle sei Shakti, cioè delle
forze femminili che sorreggono l’universo nella tradizione
tantrico-Shivaita, risalente alla cultura patriarcale dell’India
pre-ariana (civiltà della Valle dell’Indo), dove troviamo già il
nostro simbolo, nei pochi reperti
sopravvissuti ai millenni, associato a Shiva Pashupati, signore della natura.
Infatti, il “sole padano” dovrebbe essere arrivato a noi dalla Valle
dell’Indo tramite i Caldei, prima, e i Celti poi. L’ho trovato,
anche, nella colonia romana di Empuries in Spagna, dove si celebrava un
culto patriarcale
Interpretazione floreale. Il fiore rappresentato in maniera stilizzata a sei petali è il giglio e viene, spesso, associato alla doppia trinità (3 + 3 = 6). Rappresenta una coppia di valori integrantisi, ma contrapposti, cioè, una unità scissa nei sui due opposti complementari (yang-yin, luce-buio, vetta- abisso, ecc.). Dà un’idea di necessaria antitesi per formare una complementarietà contrapposta, unico presupposto per la possibilità di esistenza. Ma, essendo il simbolo bilanciato, non vi è una trinità superiore ed una inferiore, in quanto non si può distinguere un alto e un basso.
Interpretazione cromatica. Il colore verde ci riporta ancora ad un simbolo naturalistico e femminile. Nel passato il verde ha avuto valenze negative; essere al verde, verde dalla rabbia, colorito verdastro come sintomo di malattia e abbinamento col nero come colore di morte e decomposizione. Solo recentemente con la nascita di movimenti culturali naturalisti si è rivalutato il verde come colore della natura e della sua convivenza equilibrata con l’uomo. Il verde rappresenta, quindi, il simbolo dell’uomo che non lotta più contro la natura per crearsi il suo spazio vitale, ma che ritrova nella natura la Madre amorevole. Si tratta del colore della rigenerazione alla fine del vecchio ciclo esistenziale ed all’alba del nuovo. Il germoglio che sorge, dopo che il seme caduto dal frutto maturo dell’albero invecchiato ed assorbito dalla Terra fertile, è stato rinnovato e rinvigorito. Secondo la cultura Maya, l’ultimo Sole, cioè il Sole del più alto ciclo esistenziale, emanerà raggi verdi (= cosmo in armonia).
Interpretazione circa la forma. Se esaminiamo ogni foglia vediamo che essa simboleggia la mandorla, o il fuso stellare. La mandorla rappresenta la porta di passaggio tra un mondo inferiore ed uno superiore nel senso evolutivo. La stessa iconografia cristiana ufficiale la utilizza però, sembra, senza aver compreso l’equivalenza mandorla - yoni, cioè supremo principio femminile e porta di passaggio tra due livelli esistenziali. Notiamo, anche, che il fuso stellare era il centro dell’ascia bipenne, principale simbolo Cretese (cultura matriarcale).
Interpretazione geometrica. Oltre al cerchio, la figura del sole padano richiama anche il triangolo, sia con la punta rivolta in basso (femminile), che rivolta in alto (maschile), che orizzontali e contrapposti (Androginia del centro). Comunque, il valore di un simbolo è sempre tetravalente, cioè rivolto alle quattro direzioni dello spazio (simbolo della croce) e i significati logici ad esso connessi vanno ricercati in base alle sue modalità di apparizione e alle forze ad esso connesse. I riti con cui si è celebrata la nascita della Padania sono stati un richiamo dei simboli tantrici, femminili ed acquatici. Il fiume aveva il valore maternopaterno di fondatore, fertilizzatore ed unificatore. Nella preistoria anche le popolazioni che abitavano l’Europa avevano una cultura matriarcale ed adoravano la Grande Dea Madre. Si trattava di culture pacifiche schiacciate dagli invasori ariani. La cultura di questo tipo sopravvissuta più a lungo in occidente è quella Cretese che fu sopraffatta dai Micenei e da eventi naturali sfavorevoli. Simbolo cretese era il toro che, curiosamente, ritroviamo come simbolo di uno dei cantoni della Svizzera primitiva (Uri), nonchè della nostra grande città di Torino ad avvalorare la tesi che le antiche popolazioni alpine abbiano avuto, in un lontano passato, una cultura matriarcale (la vacca ed il toro ne sono il simbolo animale tipico, contrapposto all’aquila e al leone delle culture maschiliste, che sono molto comuni negli stemmi stemmi e nell’araldica. Quanti falchi negli emblemi degli attuali stati!)
Il
cerchio che racchiude il sole padano. È un altro simbolo, comune nella nostra pianura, da prendere
seriamente in considerazione in quanto richiama l’oroborus, cioè
il serpente che si morde la
coda formando, col suo corpo, una circonferenza. Il serpente è
altresì simbolo di Milano e lo si ritrova in moltissime sculture antiche
nelle nostre chiese, dove
viene associato a qualche santo che li avrebbe scacciati. In
realtà il serpente rappresenta, nel suo aspetto non richiuso su se
stesso, un’oscillazione
sinusoidale che simboleggia la ciclicità a cui sono soggetti gli eventi
umani. Ora, cosa non è mosso da un’oscillazione sinusoidale o somma di
oscillazioni sinusoidali di frequenza diversa? La scienza attuale ha
rivelato che tutto oscilla e
che neppure le più minuscole particelle subatomiche possono
essere separate dal loro aspetto di onda (Bohr). A questo proposito può
risultare curioso sapere che la forma d’onda di un sistema trifase sinusoidale
sfasato di 120° che oscilli in un campo sinusoidale di frequenza
dimezzata è esattamente corrispondente al “Sole delle Alpi”. Mi
spiego: se colleghiamo ad un
oscilloscopio dotato di quattro tracce le tre tensioni del nostro
sistema di distribuzione della corrente elettrica industriale a tre assi X
(ordinate), ed una tensione
sinusoidale di frequenza dimezzata all’asse Y (ascisse)
sul nostro schermo vedremo apparire la figura centrale del “Sole delle
Alpi”, in quanto una sinusoide oscillante in un campo sinusoidale descrive
un’ellisse a parità di frequenza tra i due campi ed un “otto”
allargato con frequenza doppia all’asse X. Lo sfasamento di 120° delle
altre due tensioni completa il
disegno. Non è stupefacente scoprire che un simbolo che si
ritrova in civiltà antichissime, lontanissime e non di certo
tecnologiche, venga disegnato
da un sistema elettrico trifase! Pensiamo, poi, ai simboli solari
(Castello Sforzesco) dove dal sole emanano sia raggi rettilinei che raggi
sinusoidali. Il simbolo è il linguaggio centrale dell’uomo e sorge
dalle profondità più remote
della psiche, io sono convinto che la “marcia in più” che
ha contraddistinto negli ultimi secoli i popoli anglo-sassoni sia stata determinata
dalla forza dei loro miti (tavola rotonda, Santo Graal, eccetera), mentre
i popoli latini si sono voltati a contemplare la trascorsa grandezza sperando
di far rivivere una civiltà la cui forza mitica si era ormai spenta e ne era
rimasta solo una vuota scatola esteriore. In questo momento di decadenza il
mito vero che può determinare una vera rinascita può essere ricercato solamente
nell’opposto più opposto perchè sempre e solo da lì può sorgere il vero
rinnovamento, come ci insegnava Jung e, se si fosse voluto comprenderLo,
anche Cristo stesso: battezzava con acqua, diceva ai ciechi di bagnarsi
gli occhi con fango (= acqua + terra) camminava sulle acque! Persino
la goffa e pericolosa rinascita dei culti satanici si inquadra in questa rinascita
dei valori sepolti e demonizzati dallo gnosticismo (che ha addomesticato
il Cristianesimo) e, più tardi dall’ideologismo, figlio tardivo dello
stesso. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dai simboli che stanno accompagnando
la rinascita della nostra regione, che deve necessariamente trovarsi
un’identità culturale distinta sia dall’antico mondo latino che dall’invecchiato
mondo sassone. D’altra parte, anche il cattolicesimo popolare delle
nostre genti è vicino ai
culti matriarcali;
Il Sole delle Alpi: un simbolo padano di Gilberto Oneto
Il sole esamero delle Alpi di Davide Fiorini