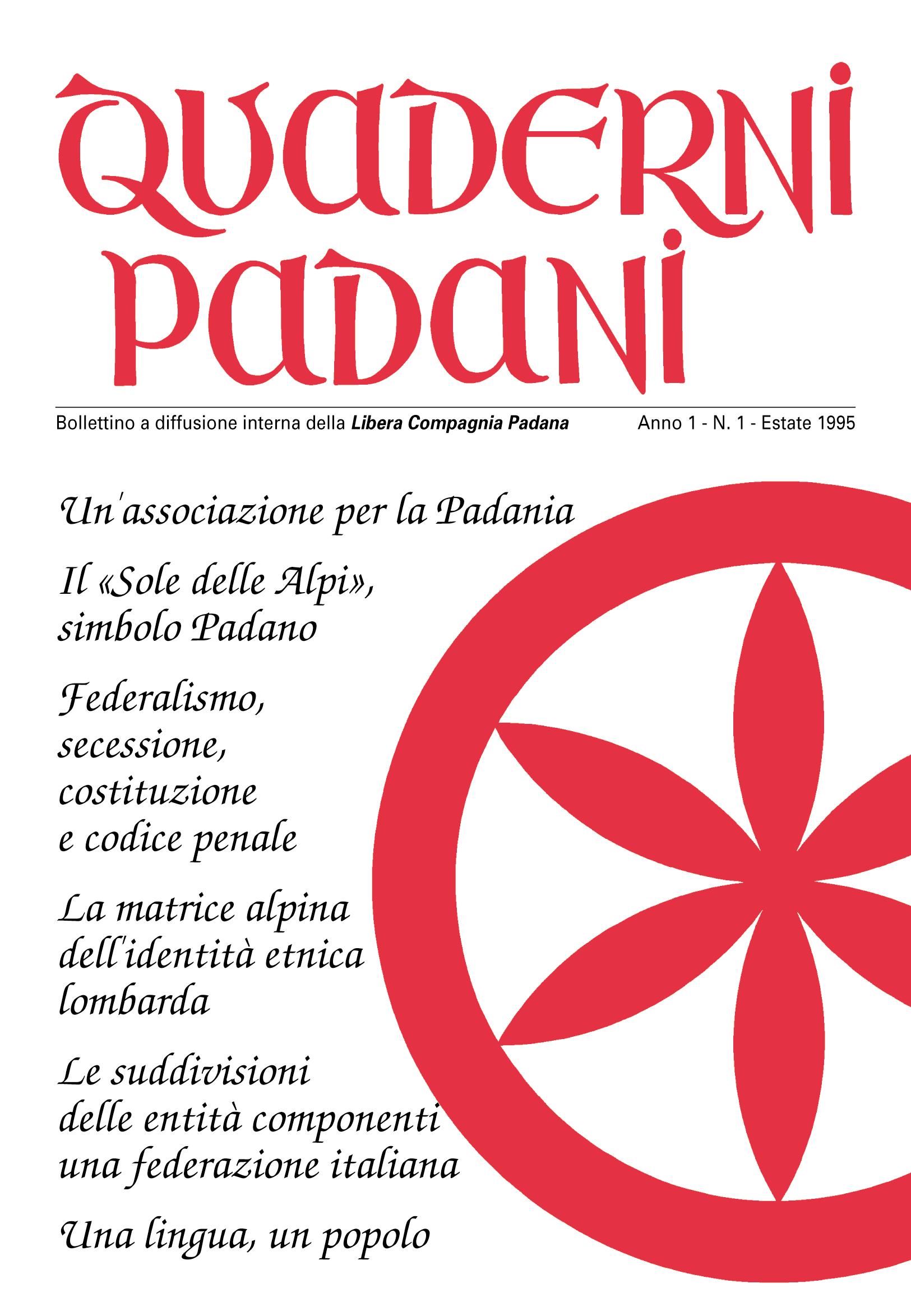|
Home
Allaricercadelsole
Il nostro obiettivo
La prima risposta
Nobili critiche
Cosa rispondere
Cos'è il Sole
Photogallery
Collabora con noi
NonsoloSole
|
Anche “
La Libera Compagnia
” ha adottato come proprio simbolo il cerchio solare a sei raggi noto
come“Sole delle Alpi” (Sol ‘d ‘j Alp). Questo incontra crescente successo come segno di
movimenti ed associazioni padanista o di gruppi impegnati nella promozione
della cultura padana in ambito locale e si è di fatto imposto come il più
popolare simbolo di riconoscimento dell’intera comunità dei popoli
Padani. La sua prima adozione “moderna” (con significati culturali e
politici) risale al 1982 quando il Sol è stato
preso come simbolo dal “Centro per lo studio della cultura brigasca e
delle altre culture delle Alpi liguri marittime” R
nì d’àigüra (“Il nido dell’aquila”). Il
successo e il più ampio riconoscimento gli sono però venuti a seguito
della pubblicazione del libro Bandiere di Libertà nel
quale è stato per la prima volta indicato come stemma (sigillo) della
Padania. Da allora la sua diffusione è stata continua: è stato adottato
– fra gli altri - dalla Associassion coltural piemonteisa
“Äl Sol ‘d j’ Alp”, dall’”ALPI – Associazione Liberi
Professionisti e Imprenditori”, dall’Unione Federalis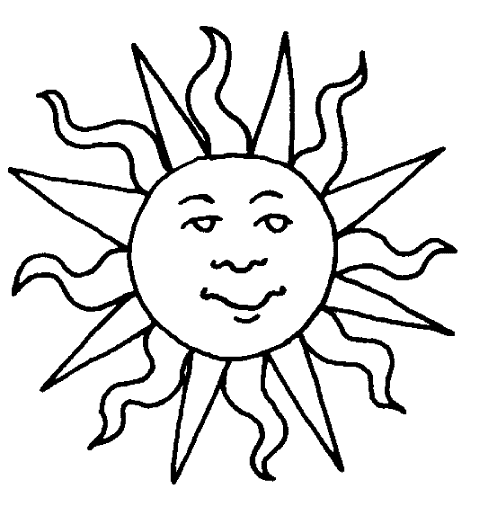 ta, dalla corrente indipendentista della
Lega Nord e - naturalmente – da “
La Libera Compagnia
Padana”. L’ampio ventaglio d’origine e di singola specificità degli
organismi che l’hanno adottato fa veramente del Sol il
simbolo della Padania, riconosciuto al di sopra
delle fazioni e dei loro obiettivi contingenti. Graficamente, il Sol
è costituito da sei petali (o raggi)
disposti all’interno di un cerchio il cui raggio fornisce la cadenzatura
dell’intera costruzione (Fig. 2). Il segno è estremamente famigliare e la sua presenza
risulta tanto continua e quotidiana da farne forse dimenticare i
molteplici significati più antichi e profondi. In realtà, esso è un
autentico concentrato di simbologie dotate di grande forza: è infatti
contemporaneamente sole, cerchio, ruota, fiore, segno religioso e -
naturalmente - la loro intricata commistione e sommatoria di valenze. Il suo nome più usato ripropone il più
evidente dei suoi significati: quello di segno solare. Da sempre le rappresentazioni grafiche più diffuse del sole
sono un cerchio, un cerchio circondato da raggi, un cerchio con un punto
centrale e la cosiddetta “ruota solare”, cerchio suddiviso in quattro
parti (“croce celtica”), in sei, otto o più parti. La sua personificazione mitologica più antica è Lug (“il
luminoso”) che è anche detto Grianainech
(“faccia di sole”) e la cui immagine
è all’origine di tutti i soli rappresentati come visi umani circondati
da raggi che sono comuni nell’iconografia di tutta l’area alpina.
Nella tradizione celtica, il sole non rappresenta solo la luce e la
brillantezza, ma anche tutto ciò che è bello, piacevole e splendido. I
testi gaelici indicano spesso il sole con la metafora “occhio del
giorno”; in irlandese occhio si dice sul, termine
bretone e padano (fonetico) che indica il sole. È questo un legame che
riporta ad intriganti accostamenti con la simbologia cristiana (ma anche orientale) e nella quale il Cristo
è spesso indicato come Sol
justitiae o come Sol invictus. Assai
interessante è anche la coincidenza di una delle figurazioni del sole più
comuni e diffuse (cerchio con punto centrale) con un segno di
rappresentazione femminile (segno di sesso femminile, di fecondità, della
Terra Madre) che riporta al fatto che il sole nelle lingue celtiche e
germaniche (e in tutte le lingue indoeuropee antiche) sia di genere
femminile. Di derivazione solare è anche la rappresentazione della
ruota, presente in tutte le simbologie più antiche. Essa si rapporta al
mondo del “divenire” e della creazione continua attorno ad un centro
immobile. La sua forma circolare ricorda l’uroburos, simbolo dell’eterno ritorno o, in generale,
dell’eternità. Essa simboleggia anche un luogo sacro (nemeton) circoscritto e difeso che benissimo si adatta alla terra
Padana racchiusa dai mari e dai monti e gravitante su un centro fisico e ta, dalla corrente indipendentista della
Lega Nord e - naturalmente – da “
La Libera Compagnia
Padana”. L’ampio ventaglio d’origine e di singola specificità degli
organismi che l’hanno adottato fa veramente del Sol il
simbolo della Padania, riconosciuto al di sopra
delle fazioni e dei loro obiettivi contingenti. Graficamente, il Sol
è costituito da sei petali (o raggi)
disposti all’interno di un cerchio il cui raggio fornisce la cadenzatura
dell’intera costruzione (Fig. 2). Il segno è estremamente famigliare e la sua presenza
risulta tanto continua e quotidiana da farne forse dimenticare i
molteplici significati più antichi e profondi. In realtà, esso è un
autentico concentrato di simbologie dotate di grande forza: è infatti
contemporaneamente sole, cerchio, ruota, fiore, segno religioso e -
naturalmente - la loro intricata commistione e sommatoria di valenze. Il suo nome più usato ripropone il più
evidente dei suoi significati: quello di segno solare. Da sempre le rappresentazioni grafiche più diffuse del sole
sono un cerchio, un cerchio circondato da raggi, un cerchio con un punto
centrale e la cosiddetta “ruota solare”, cerchio suddiviso in quattro
parti (“croce celtica”), in sei, otto o più parti. La sua personificazione mitologica più antica è Lug (“il
luminoso”) che è anche detto Grianainech
(“faccia di sole”) e la cui immagine
è all’origine di tutti i soli rappresentati come visi umani circondati
da raggi che sono comuni nell’iconografia di tutta l’area alpina.
Nella tradizione celtica, il sole non rappresenta solo la luce e la
brillantezza, ma anche tutto ciò che è bello, piacevole e splendido. I
testi gaelici indicano spesso il sole con la metafora “occhio del
giorno”; in irlandese occhio si dice sul, termine
bretone e padano (fonetico) che indica il sole. È questo un legame che
riporta ad intriganti accostamenti con la simbologia cristiana (ma anche orientale) e nella quale il Cristo
è spesso indicato come Sol
justitiae o come Sol invictus. Assai
interessante è anche la coincidenza di una delle figurazioni del sole più
comuni e diffuse (cerchio con punto centrale) con un segno di
rappresentazione femminile (segno di sesso femminile, di fecondità, della
Terra Madre) che riporta al fatto che il sole nelle lingue celtiche e
germaniche (e in tutte le lingue indoeuropee antiche) sia di genere
femminile. Di derivazione solare è anche la rappresentazione della
ruota, presente in tutte le simbologie più antiche. Essa si rapporta al
mondo del “divenire” e della creazione continua attorno ad un centro
immobile. La sua forma circolare ricorda l’uroburos, simbolo dell’eterno ritorno o, in generale,
dell’eternità. Essa simboleggia anche un luogo sacro (nemeton) circoscritto e difeso che benissimo si adatta alla terra
Padana racchiusa dai mari e dai monti e gravitante su un centro fisico e 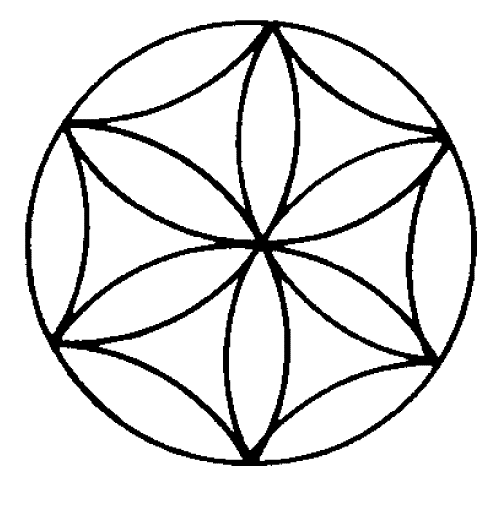 sacrale:
l'etimo di Milano va possibilmente ritrovato secondo alcuni non solo in Mediolanum ma anche in Medionemeton. Nelle dottrine magiche il cerchio ha una funzione di difesa
dagli spiriti cattivi. Talune danze circolari (girotondo, rondò, ronde) possono
essere considerate “cerchi danzati”, con origini apotropaiche
spesso collegate con i festeggiamenti dei solstizi e con il sole. Il
legame solare della ruota è comunque
evidente: nel solstizio d’estate ruote infuocate venivano fatte rotolare
giù dai monti in un rito che ricorda la “ruota di fuoco” celtica e la
sua doppia rotazione. La ruota è attributo
di Taranis (“dio della ruota”) ed ha la stessa funzione del fulmine di
Giove: ancora un simbolo solare che si connette con le coppelle, con le
“pietre di tuono” e con tutto l’universo simbolico delle incisioni
rupestri alpine. Non è infatti un caso che incisioni di ruote si trovino
lungo tutto l’arco delle Alpi. Sul calderone di Gundestrup è
rappresentato un guerriero (“servitore della ruota”) che tiene
sollevata e fa girare la ruota cosmica. Alla ruota sono legati anche i
diffusi simboli cristiani della “ruota della vita” e della “ruota
della fortuna” (mai ferma ma sempre soggetta a mutamento), spessissimo
rappresentata a sei raggi. A questa fa curioso riferimento il decimo degli “Arcani
maggiori” dei Tarocchi che sta ad indicare “il salire e lo scendere
della vita, il destino, l’inevitabilità”. Stranamente, il segno della
ruota con sei raggi è anche il simbolo alchemico del verderame. Legato alla ruota è il significato di rotazione che accomuna
una vastissima gamma di segni antichissimi: dal triscele (triskel) allo
svastica, soprattutto nella sua versione basca di Lau buru (“quattro
raggi”). In questo caso la connessione con il nostro Sol non è ti
tipo grafico (il Sole delle Alpi non ha segni di rotazione) ma può essere
ritrovata nel suo processo costruttivo che avviene mediante successive
puntature del compasso sulla circonferenza che producono un doppio
moto rotatorio: quello del compasso
e quello della punta sulla circonferenza originaria. In alcune culture
locali, il Sol è anche chiamato “Fiore delle Alpi” o “Margherita a
sei petali” per il suo
aspetto che richiama rappresentazioni stilizzate di crisantemi o di fior
di loto che sono però - ancora una volta - simboli solari. I fiori
infatti simboleggiano l’energia vitale, la gioia di vivere, la fine
dell’inverno. Un segno così carico di metafore come il Sol non poteva
non avere anche profondi significati religiosi o essere ripreso da simbologie religiose
cristiane.
Risulta facile ed immediato il suo accostamento grafico – mediato dalla
simbologia solare e da quella della ruota - con il Chrismon,
monogramma formato dalle iniziali greche di Cristo, X (chi) e P (rho).La ripartizione in sei non può poi non far venire in mente
anche il “Sigillo di Salomone” o il Maghen
David (“Stella di Davide”). Quest'ultimo elemento porta a fare alcune considerazioni sul
sei, un numero non in sé ricchissimo di valenze simboliche: è infatti
quasi solo ricordato per la creazione del mondo, definita Hexaemeron (“Opera
dei sei giorni”). La sua importanza cresce invece di molto se lo si
intende come il doppio di tre o come la sommatoria dei primi tre numeri
(1+2+3). Il tre è numero sacro per eccellenza, in particolare presso la
cultura celta. Come unione di tre numeri diversi in
entità, il sei si rivela poi invece perfetto a rappresentare
la Padania
, somma organica di componenti molto diverse fra di loro come dimensione.
Un corollario recente di questa considerazione è quello che lega il Sol alla rappresentazione dei sei ceppi etno-linguistici che
popolano
la Padania
: il Celto- italico (Piemontese, Ligure, Lombardo, Emiliano e Romagnolo),
il Veneto, il Tirolese (Südtiroler e Welschtiroler), il Friulano, il Ladino (e Grigionese) e l’Occitano-Arpitano.
Per quanto
concerne il suo uso storico, il Sole delle Alpi è sicuramente un segno
antichissimo: ruote si trovano in tutte le incisioni rupestri
proto-storiche dell’arco alpino e dell’appennino ligure. Il suo legame
con il mondo celtico è di tipo simbolico (si tratta - come visto - di
significati in gran parte generati da quel mondo e lì ampiamente
presenti), di tipo geometrico (la costruzione a cerchi successivi è
tipica delle geometrie celtiche ad intreccio) ed è documentata da
numerose presenze archeologiche. Una particolare concentrazione di Sol in epoca celtica si ritrova in Galizia e fa pensare - vedendo
la diffusione del segno del sole a ruota nell’arco alpino soprattutto
occidentale - ad una ancora più lontana comune origine ligure. La sua fortuna continua nel Medioevo (con particolare
ricorrenza nelle decorazioni longobarde) e prosegue ininterrotta fino ad
oggi. La presenza nell’iconografia longobarda può – in particolare -
spiegare la sua attuale diffusione anche nelle alpi orientali e in molti
paesi, abitati da popolazioni di ceppo celtogermanico - con esse
confinanti. Più in generale, le ricorrenze più consistenti si hanno –
fuori dalla Padania e dall’arco alpino - soprattutto nei paesi celti,
celto- romanzi e celto-germanici: Galizia, Catalogna, Occitania, Baviera,
Polonia meridionale, Slovenia e Transilvania. Risulta estremamente interessante considerare il tipo di uso
piuttosto peculiare che ne è stato fatto e che denota una notevole
costanza nel tempo e nello spazio. Innanzitutto si deve notare che il Sol non ha mai
avuto utilizzi “nobili”: esso non esiste nell’araldica nobiliare e
se ne trovano tracce solo insignificanti su manufatti (architetture,
monumenti, decorazioni, ecc.) aulici prodotti da culture dominanti. La sua
diffusione è invece incredibilmente massiccia e capillare nell’arte e
nell’iconografia popolare: esso orna gli edifici modesti, decora i
costumi popolari e - soprattutto - gli utensili e gli oggetti della vita
quotidiana. Lo si ritrova costantemente – ad esempio - sugli stampi per
il burro, sui mobili, sui finimenti degli animali e sugli attrezzi di
lavoro con particolare rilevanza per tutti i manufatti che sono vitali per la
vita della comunità. La sua particolare fattura geometrica ne fa un
segno “di incisione” e di decorazione pittorica (e non di ricamo o
scultura in rilievo) che meglio si presta all’utilizzo della pietra, del
legno e dell’intonaco. Per questo motivo, lo si trova soprattutto nelle
aree deve questi materiali sono dominanti e, quindi, in Padania. La sua
diffusione in queste aree deve molto anche allo speciale procedimento di
tracciamento che richiede l’impiego esclusivo del compasso (strumento di
scalpellini e falegnami) che non può non richiamare taluni dei
significati simbolici di questo strumento: nei riti iniziatici delle
corporazioni “del legno e della pietra” le punte del compasso univano
il cuore dell’iniziato a quelli di tutti gli altri sodali. Questo legame
con il compasso serve anche a spiegare la grande diffusione della versione
con la circonferenza “a petali”. Si può sicuramente con tutto ciò affermare che si tratta del
segno più diffuso in Padania nella cultura subalterna, in quella cultura
popolare contadina, montanara ed artigiana che è ancora radicata e ricca
e che rappresenta il più forte e vitale tessuto connettivo del paese.
Anche per questo non ci può essere simbolo migliore del Sol
per rappresentare un paese che ha sempre
mantenuto la sua unità culturale anche sotto secolari divisioni politiche
e culture dominanti, spesso forestiere ed imposte con la forza o con
l’inganno. Ora che questa terra sta faticosamente lottando per ritrovare
la propria cultura più profonda, non può darsi sigillo più antico,
ricco e popolare di questo che significa luce, fecondità e ritorno eterno
alla propria tradizione ed alle proprie radici più antiche. sacrale:
l'etimo di Milano va possibilmente ritrovato secondo alcuni non solo in Mediolanum ma anche in Medionemeton. Nelle dottrine magiche il cerchio ha una funzione di difesa
dagli spiriti cattivi. Talune danze circolari (girotondo, rondò, ronde) possono
essere considerate “cerchi danzati”, con origini apotropaiche
spesso collegate con i festeggiamenti dei solstizi e con il sole. Il
legame solare della ruota è comunque
evidente: nel solstizio d’estate ruote infuocate venivano fatte rotolare
giù dai monti in un rito che ricorda la “ruota di fuoco” celtica e la
sua doppia rotazione. La ruota è attributo
di Taranis (“dio della ruota”) ed ha la stessa funzione del fulmine di
Giove: ancora un simbolo solare che si connette con le coppelle, con le
“pietre di tuono” e con tutto l’universo simbolico delle incisioni
rupestri alpine. Non è infatti un caso che incisioni di ruote si trovino
lungo tutto l’arco delle Alpi. Sul calderone di Gundestrup è
rappresentato un guerriero (“servitore della ruota”) che tiene
sollevata e fa girare la ruota cosmica. Alla ruota sono legati anche i
diffusi simboli cristiani della “ruota della vita” e della “ruota
della fortuna” (mai ferma ma sempre soggetta a mutamento), spessissimo
rappresentata a sei raggi. A questa fa curioso riferimento il decimo degli “Arcani
maggiori” dei Tarocchi che sta ad indicare “il salire e lo scendere
della vita, il destino, l’inevitabilità”. Stranamente, il segno della
ruota con sei raggi è anche il simbolo alchemico del verderame. Legato alla ruota è il significato di rotazione che accomuna
una vastissima gamma di segni antichissimi: dal triscele (triskel) allo
svastica, soprattutto nella sua versione basca di Lau buru (“quattro
raggi”). In questo caso la connessione con il nostro Sol non è ti
tipo grafico (il Sole delle Alpi non ha segni di rotazione) ma può essere
ritrovata nel suo processo costruttivo che avviene mediante successive
puntature del compasso sulla circonferenza che producono un doppio
moto rotatorio: quello del compasso
e quello della punta sulla circonferenza originaria. In alcune culture
locali, il Sol è anche chiamato “Fiore delle Alpi” o “Margherita a
sei petali” per il suo
aspetto che richiama rappresentazioni stilizzate di crisantemi o di fior
di loto che sono però - ancora una volta - simboli solari. I fiori
infatti simboleggiano l’energia vitale, la gioia di vivere, la fine
dell’inverno. Un segno così carico di metafore come il Sol non poteva
non avere anche profondi significati religiosi o essere ripreso da simbologie religiose
cristiane.
Risulta facile ed immediato il suo accostamento grafico – mediato dalla
simbologia solare e da quella della ruota - con il Chrismon,
monogramma formato dalle iniziali greche di Cristo, X (chi) e P (rho).La ripartizione in sei non può poi non far venire in mente
anche il “Sigillo di Salomone” o il Maghen
David (“Stella di Davide”). Quest'ultimo elemento porta a fare alcune considerazioni sul
sei, un numero non in sé ricchissimo di valenze simboliche: è infatti
quasi solo ricordato per la creazione del mondo, definita Hexaemeron (“Opera
dei sei giorni”). La sua importanza cresce invece di molto se lo si
intende come il doppio di tre o come la sommatoria dei primi tre numeri
(1+2+3). Il tre è numero sacro per eccellenza, in particolare presso la
cultura celta. Come unione di tre numeri diversi in
entità, il sei si rivela poi invece perfetto a rappresentare
la Padania
, somma organica di componenti molto diverse fra di loro come dimensione.
Un corollario recente di questa considerazione è quello che lega il Sol alla rappresentazione dei sei ceppi etno-linguistici che
popolano
la Padania
: il Celto- italico (Piemontese, Ligure, Lombardo, Emiliano e Romagnolo),
il Veneto, il Tirolese (Südtiroler e Welschtiroler), il Friulano, il Ladino (e Grigionese) e l’Occitano-Arpitano.
Per quanto
concerne il suo uso storico, il Sole delle Alpi è sicuramente un segno
antichissimo: ruote si trovano in tutte le incisioni rupestri
proto-storiche dell’arco alpino e dell’appennino ligure. Il suo legame
con il mondo celtico è di tipo simbolico (si tratta - come visto - di
significati in gran parte generati da quel mondo e lì ampiamente
presenti), di tipo geometrico (la costruzione a cerchi successivi è
tipica delle geometrie celtiche ad intreccio) ed è documentata da
numerose presenze archeologiche. Una particolare concentrazione di Sol in epoca celtica si ritrova in Galizia e fa pensare - vedendo
la diffusione del segno del sole a ruota nell’arco alpino soprattutto
occidentale - ad una ancora più lontana comune origine ligure. La sua fortuna continua nel Medioevo (con particolare
ricorrenza nelle decorazioni longobarde) e prosegue ininterrotta fino ad
oggi. La presenza nell’iconografia longobarda può – in particolare -
spiegare la sua attuale diffusione anche nelle alpi orientali e in molti
paesi, abitati da popolazioni di ceppo celtogermanico - con esse
confinanti. Più in generale, le ricorrenze più consistenti si hanno –
fuori dalla Padania e dall’arco alpino - soprattutto nei paesi celti,
celto- romanzi e celto-germanici: Galizia, Catalogna, Occitania, Baviera,
Polonia meridionale, Slovenia e Transilvania. Risulta estremamente interessante considerare il tipo di uso
piuttosto peculiare che ne è stato fatto e che denota una notevole
costanza nel tempo e nello spazio. Innanzitutto si deve notare che il Sol non ha mai
avuto utilizzi “nobili”: esso non esiste nell’araldica nobiliare e
se ne trovano tracce solo insignificanti su manufatti (architetture,
monumenti, decorazioni, ecc.) aulici prodotti da culture dominanti. La sua
diffusione è invece incredibilmente massiccia e capillare nell’arte e
nell’iconografia popolare: esso orna gli edifici modesti, decora i
costumi popolari e - soprattutto - gli utensili e gli oggetti della vita
quotidiana. Lo si ritrova costantemente – ad esempio - sugli stampi per
il burro, sui mobili, sui finimenti degli animali e sugli attrezzi di
lavoro con particolare rilevanza per tutti i manufatti che sono vitali per la
vita della comunità. La sua particolare fattura geometrica ne fa un
segno “di incisione” e di decorazione pittorica (e non di ricamo o
scultura in rilievo) che meglio si presta all’utilizzo della pietra, del
legno e dell’intonaco. Per questo motivo, lo si trova soprattutto nelle
aree deve questi materiali sono dominanti e, quindi, in Padania. La sua
diffusione in queste aree deve molto anche allo speciale procedimento di
tracciamento che richiede l’impiego esclusivo del compasso (strumento di
scalpellini e falegnami) che non può non richiamare taluni dei
significati simbolici di questo strumento: nei riti iniziatici delle
corporazioni “del legno e della pietra” le punte del compasso univano
il cuore dell’iniziato a quelli di tutti gli altri sodali. Questo legame
con il compasso serve anche a spiegare la grande diffusione della versione
con la circonferenza “a petali”. Si può sicuramente con tutto ciò affermare che si tratta del
segno più diffuso in Padania nella cultura subalterna, in quella cultura
popolare contadina, montanara ed artigiana che è ancora radicata e ricca
e che rappresenta il più forte e vitale tessuto connettivo del paese.
Anche per questo non ci può essere simbolo migliore del Sol
per rappresentare un paese che ha sempre
mantenuto la sua unità culturale anche sotto secolari divisioni politiche
e culture dominanti, spesso forestiere ed imposte con la forza o con
l’inganno. Ora che questa terra sta faticosamente lottando per ritrovare
la propria cultura più profonda, non può darsi sigillo più antico,
ricco e popolare di questo che significa luce, fecondità e ritorno eterno
alla propria tradizione ed alle proprie radici più antiche.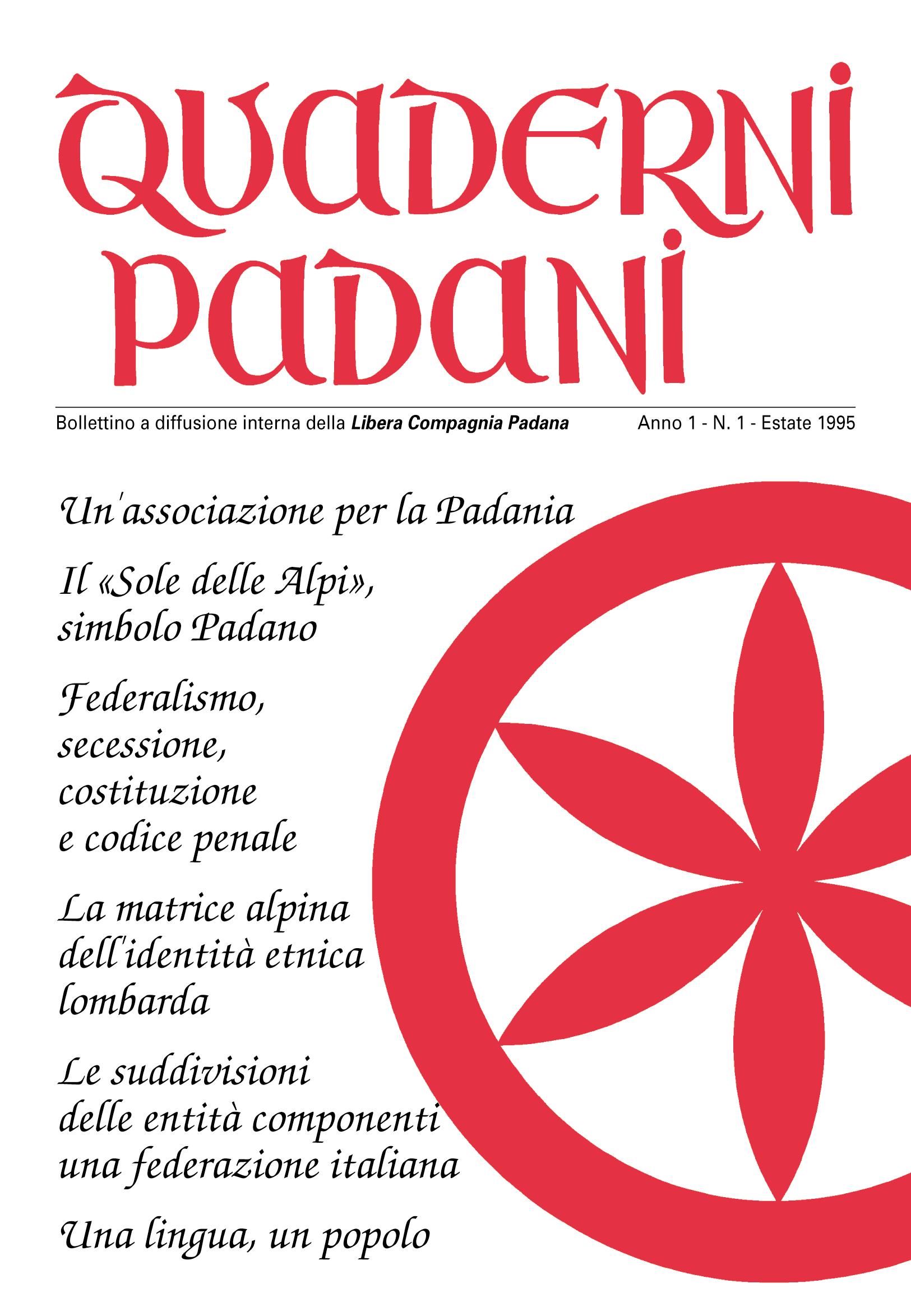
Il sole
esamero delle Alpi di Davide Fiorini
Il Sole delle
Alpi: altre interpretazioni di Giuseppe Aloè
|
|
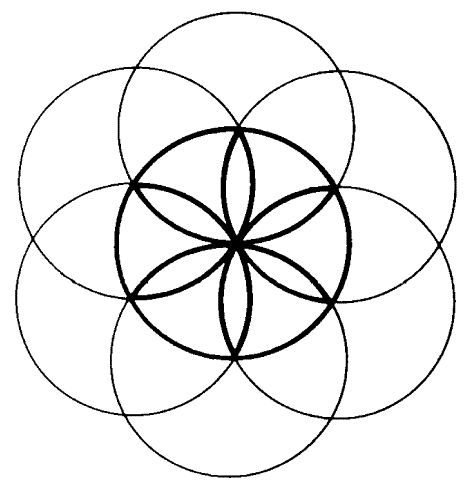
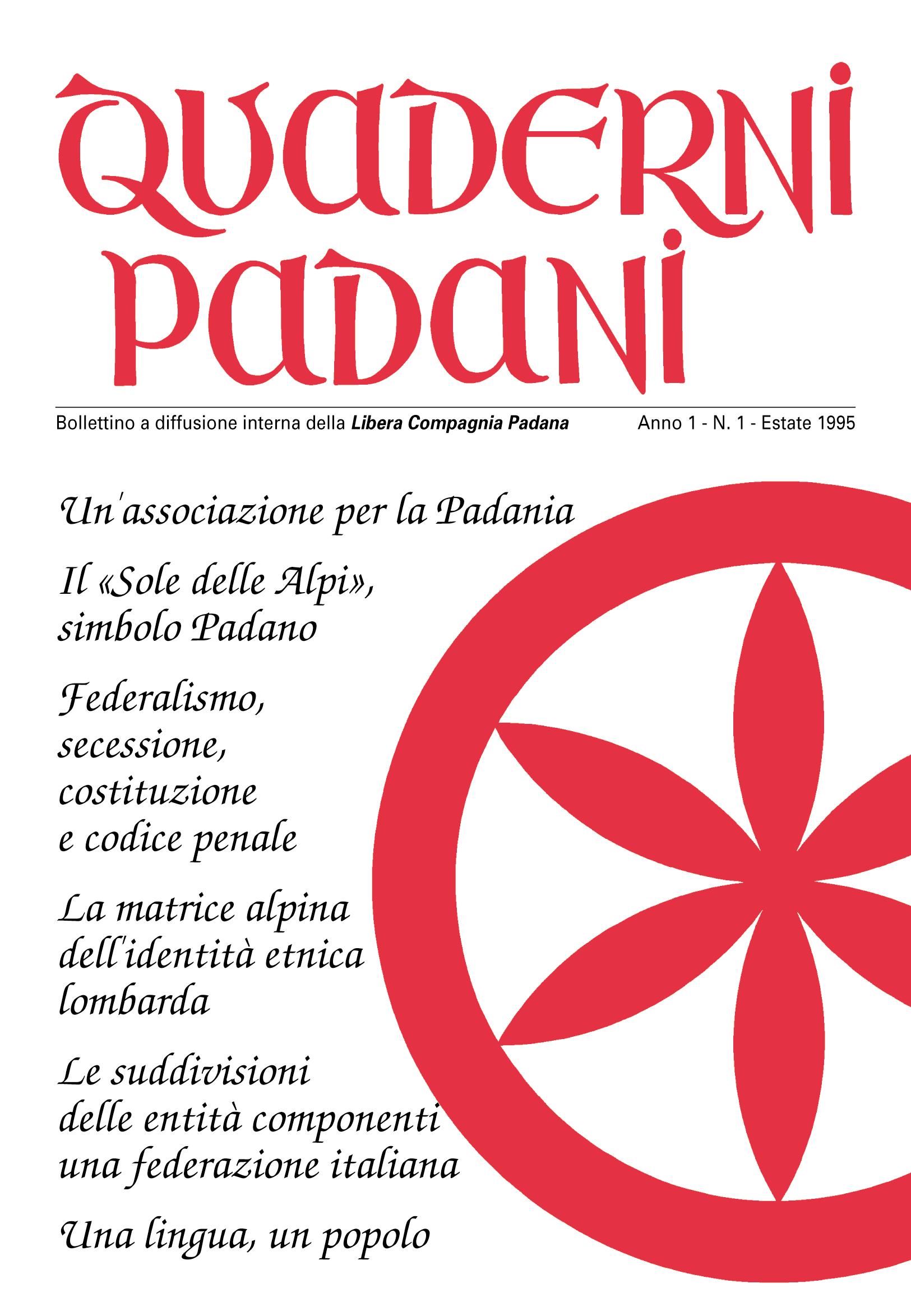
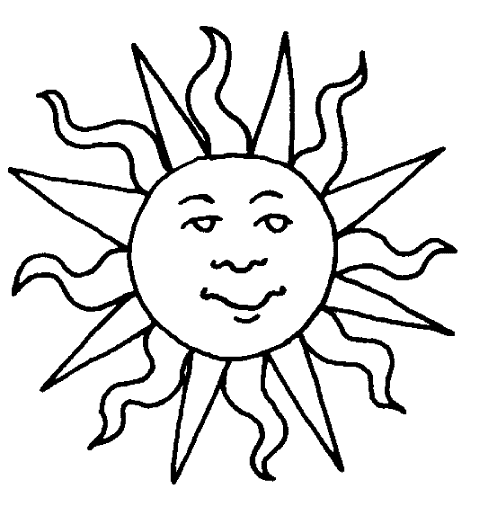 ta, dalla corrente indipendentista della
Lega Nord e - naturalmente – da “
ta, dalla corrente indipendentista della
Lega Nord e - naturalmente – da “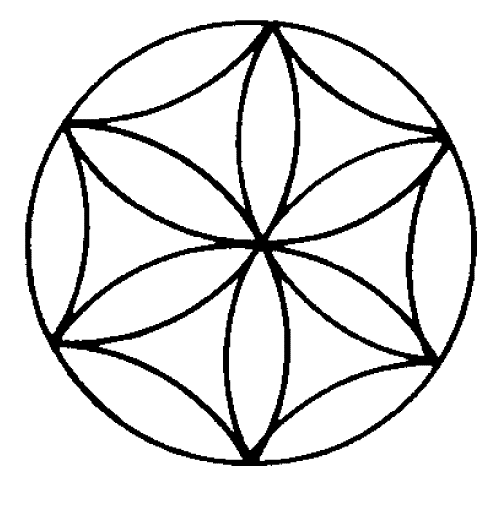 sacrale:
l'etimo di Milano va possibilmente ritrovato secondo alcuni non solo in Mediolanum ma anche in Medionemeton. Nelle dottrine magiche il cerchio ha una funzione di difesa
dagli spiriti cattivi. Talune danze circolari (girotondo, rondò, ronde) possono
essere considerate “cerchi danzati”, con origini apotropaiche
spesso collegate con i festeggiamenti dei solstizi e con il sole. Il
legame solare della ruota è comunque
evidente: nel solstizio d’estate ruote infuocate venivano fatte rotolare
giù dai monti in un rito che ricorda la “ruota di fuoco” celtica e la
sua doppia rotazione. La ruota è attributo
di Taranis (“dio della ruota”) ed ha la stessa funzione del fulmine di
Giove: ancora un simbolo solare che si connette con le coppelle, con le
“pietre di tuono” e con tutto l’universo simbolico delle incisioni
rupestri alpine. Non è infatti un caso che incisioni di ruote si trovino
lungo tutto l’arco delle Alpi. Sul calderone di Gundestrup è
rappresentato un guerriero (“servitore della ruota”) che tiene
sollevata e fa girare la ruota cosmica. Alla ruota sono legati anche i
diffusi simboli cristiani della “ruota della vita” e della “ruota
della fortuna” (mai ferma ma sempre soggetta a mutamento), spessissimo
rappresentata a sei raggi. A questa fa curioso riferimento il decimo degli “Arcani
maggiori” dei Tarocchi che sta ad indicare “il salire e lo scendere
della vita, il destino, l’inevitabilità”. Stranamente, il segno della
ruota con sei raggi è anche il simbolo alchemico del verderame. Legato alla ruota è il significato di rotazione che accomuna
una vastissima gamma di segni antichissimi: dal triscele (triskel) allo
svastica, soprattutto nella sua versione basca di Lau buru (“quattro
raggi”). In questo caso la connessione con il nostro Sol non è ti
tipo grafico (il Sole delle Alpi non ha segni di rotazione) ma può essere
ritrovata nel suo processo costruttivo che avviene mediante successive
puntature del compasso sulla circonferenza che producono un doppio
moto rotatorio: quello del compasso
e quello della punta sulla circonferenza originaria. In alcune culture
locali, il Sol è anche chiamato “Fiore delle Alpi” o “Margherita a
sei petali” per il suo
aspetto che richiama rappresentazioni stilizzate di crisantemi o di fior
di loto che sono però - ancora una volta - simboli solari. I fiori
infatti simboleggiano l’energia vitale, la gioia di vivere, la fine
dell’inverno. Un segno così carico di metafore come il Sol non poteva
non avere anche profondi significati religiosi o essere ripreso da simbologie religiose
cristiane.
Risulta facile ed immediato il suo accostamento grafico – mediato dalla
simbologia solare e da quella della ruota - con il Chrismon,
monogramma formato dalle iniziali greche di Cristo, X (chi) e P (rho).La ripartizione in sei non può poi non far venire in mente
anche il “Sigillo di Salomone” o il Maghen
David (“Stella di Davide”). Quest'ultimo elemento porta a fare alcune considerazioni sul
sei, un numero non in sé ricchissimo di valenze simboliche: è infatti
quasi solo ricordato per la creazione del mondo, definita Hexaemeron (“Opera
dei sei giorni”). La sua importanza cresce invece di molto se lo si
intende come il doppio di tre o come la sommatoria dei primi tre numeri
(1+2+3). Il tre è numero sacro per eccellenza, in particolare presso la
cultura celta. Come unione di tre numeri diversi in
entità, il sei si rivela poi invece perfetto a rappresentare
sacrale:
l'etimo di Milano va possibilmente ritrovato secondo alcuni non solo in Mediolanum ma anche in Medionemeton. Nelle dottrine magiche il cerchio ha una funzione di difesa
dagli spiriti cattivi. Talune danze circolari (girotondo, rondò, ronde) possono
essere considerate “cerchi danzati”, con origini apotropaiche
spesso collegate con i festeggiamenti dei solstizi e con il sole. Il
legame solare della ruota è comunque
evidente: nel solstizio d’estate ruote infuocate venivano fatte rotolare
giù dai monti in un rito che ricorda la “ruota di fuoco” celtica e la
sua doppia rotazione. La ruota è attributo
di Taranis (“dio della ruota”) ed ha la stessa funzione del fulmine di
Giove: ancora un simbolo solare che si connette con le coppelle, con le
“pietre di tuono” e con tutto l’universo simbolico delle incisioni
rupestri alpine. Non è infatti un caso che incisioni di ruote si trovino
lungo tutto l’arco delle Alpi. Sul calderone di Gundestrup è
rappresentato un guerriero (“servitore della ruota”) che tiene
sollevata e fa girare la ruota cosmica. Alla ruota sono legati anche i
diffusi simboli cristiani della “ruota della vita” e della “ruota
della fortuna” (mai ferma ma sempre soggetta a mutamento), spessissimo
rappresentata a sei raggi. A questa fa curioso riferimento il decimo degli “Arcani
maggiori” dei Tarocchi che sta ad indicare “il salire e lo scendere
della vita, il destino, l’inevitabilità”. Stranamente, il segno della
ruota con sei raggi è anche il simbolo alchemico del verderame. Legato alla ruota è il significato di rotazione che accomuna
una vastissima gamma di segni antichissimi: dal triscele (triskel) allo
svastica, soprattutto nella sua versione basca di Lau buru (“quattro
raggi”). In questo caso la connessione con il nostro Sol non è ti
tipo grafico (il Sole delle Alpi non ha segni di rotazione) ma può essere
ritrovata nel suo processo costruttivo che avviene mediante successive
puntature del compasso sulla circonferenza che producono un doppio
moto rotatorio: quello del compasso
e quello della punta sulla circonferenza originaria. In alcune culture
locali, il Sol è anche chiamato “Fiore delle Alpi” o “Margherita a
sei petali” per il suo
aspetto che richiama rappresentazioni stilizzate di crisantemi o di fior
di loto che sono però - ancora una volta - simboli solari. I fiori
infatti simboleggiano l’energia vitale, la gioia di vivere, la fine
dell’inverno. Un segno così carico di metafore come il Sol non poteva
non avere anche profondi significati religiosi o essere ripreso da simbologie religiose
cristiane.
Risulta facile ed immediato il suo accostamento grafico – mediato dalla
simbologia solare e da quella della ruota - con il Chrismon,
monogramma formato dalle iniziali greche di Cristo, X (chi) e P (rho).La ripartizione in sei non può poi non far venire in mente
anche il “Sigillo di Salomone” o il Maghen
David (“Stella di Davide”). Quest'ultimo elemento porta a fare alcune considerazioni sul
sei, un numero non in sé ricchissimo di valenze simboliche: è infatti
quasi solo ricordato per la creazione del mondo, definita Hexaemeron (“Opera
dei sei giorni”). La sua importanza cresce invece di molto se lo si
intende come il doppio di tre o come la sommatoria dei primi tre numeri
(1+2+3). Il tre è numero sacro per eccellenza, in particolare presso la
cultura celta. Come unione di tre numeri diversi in
entità, il sei si rivela poi invece perfetto a rappresentare